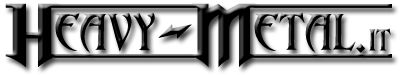Allarme rientrato. Da Roadrunner a Nuclear Blast il passo è breve, ed apparentemente anche indolore, per i Chimaira che, contro i pronostici dei più, continuano nella loro spinta evolutiva senza cedere il passo a temibili compromessi prevedibilmente distruttivi per le sonorità da loro espresse. Una volta accertata la scongiura di eventuali sciagure, c’è anche il tempo di gioire per il ritorno dietro le pelli di quello straordinario musicista che porta il nome di Andols Herrick e di tutti i valori aggiunti che la sua presenza può portare all’interno di un disco.
Prodotto splendidamente, dal punto di vista prettamente musicale ‘Resurrection’ è un’uscita che, a dispetto del titolo, non segna alcuna rinascita del passato remoto, quanto un’intelligente maturazione e crescita di quello più recente. Se, infatti, ‘The Impossibility Of Resason’ rispecchiava una moderna semplicità marziale e l’omonimo simboleggiava l’anima intricata della band, l’opera in questione riesce ad equilibrare quelle due formule in una mistura fresca e piacevole. I suoni che avevano caratterizzato il complesso album precedente si aprono, infatti, ad atmosfere sempre cupe e distaccate ma definite in maniera linearmente più chiara. I brani si mantengono sempre e comunque cattivi e, pur essendo pervasi da un intelligente e misurato apporto dei samples, riescono a toccare picchi di aggressività davvero impressionanti. Una ferocia musicale scagliata in modo preciso e compatto senza divagare ma sempre tenendo presente l’originalità stilistica che ha reso celebre la formazione di Cleaveland. Il songwriting, moderno nell’accezione pratica (e non elettronica) del termine, si riconduce così a quel thrash dal sapore tecnico ed industriale che tenta di variare e respirare molto di più rispetto ai tre predecessori. In uno scenario come quello illustrato, il supporto pratico, nel perseguire un obiettivo per altri solo pretenzioso, è fornito dalla perizia tecnica della band che si mostra generosa nell’osare l’esplorazione di territori apparentemente estranei come quelli del death ed, anche e soprattutto, del progressive. Un quadro, nonostante la sua iperbolica freddezza sonora, piacevole da contemplare ed in cui la voce acida e gracchiante di un Mark Hunter sempre più intraprendente completa un lavoro innegabilmente fascinoso. Un’attrattiva ancora lontana dal capolavoro, a causa di qualche distrazione e del solito episodio flop (“Killing The Beast”) che, pur irritando a tratti, non riescono ad alterare il candido valore di un disco originale ed ancora una volta completo.