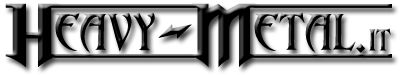Un’esile quanto inutile diga, costituita da dubbi, sentenze anticipate e cecità di un certo tipo di audience, aleggiava minacciosa di fronte al nuovo nato in casa Cannibal Corpse. Diciassette anni di carriera senza nei, dieci album salutati da plebisciti di applausi, uno stile ed un’attitudine fonte ispirativa per chiunque voglia confrontarsi col genere e basta poco per esprimersi prematuramente e tentare di far valere il proprio “occhio lungo”. Fortunatamente per il panorama estremo e di chi si è sempre prodigato per dargli un senso, però, i pregiudizi musicali, come chiunque se ne faccia portatore, restano fini a sè stessi dove la qualità arriva ad annichilire certe antipatie per un frontman di primissima classe, ritorni in line-up poco graditi ed un artwork privo di personaggi biblici ridotti a carcasse umane.
E come ogni fiume in piena che si rispetti, fedeli ad una carriera costantemente al top, i Cannibal Corpse disintegrano l’inutile diga di cui sopra con un ottimo disco che, naturalmente, non tenta stupidamente di allontanarsi da ciò che la band stessa ha inventato.
Una copertina semplicissima, che in linea col passato ha solo il rosso sangue, sulla quale sovrasta un titolo secco, forte, dal sapore imperativo, introducono freddamente l’ascoltatore ad un contenuto che si rivelerà il solito massacro. Senza preamboli, infatti, si parte con “The Time To Kill Is Now” in cui l’urlo inconfondibile di Fisher attanaglia la vittima di turno per quella che sarà un’efficace violenza sonora di circa quaranta minuti. Fin dai primi riff, che racchiuderanno il modus operandi dell’intero disco, s’intuisce il dolore procurato dalle infallibili armi dei cinque statunitensi. La formula, iterata con perizia e senza un secondo di noia per tredici brani, è quella che ha caratterizzato i Cannibal Corpse da ‘Vile’ ad oggi: un approccio basato su doti tecniche ineccepibili e riff da capogiro sempre bassi e d’impatto spezzati da stacchi dissonanti ormai da trademark. Aiutata a venire fuori dalla stupefacente produzione ad opera di Erik Rutan, lecitamente definibile la migliore nella storia del gruppo, impressiona, al solito, la sezione ritmica in cui gli unici due membri originari (Webster e Mazurkiewics) giocano chirurgicamente su velocità e varietà riconducendosi spesso a tempi slayerani. Se in “Kill”, infatti, c’è qualcosa che risulta – prendendo con le molle il termine – “diverso” è proprio la ricorsione di strutture thrash molto più definita che in passato. Tutto il resto è indiscutibile attitudine, coerenza con sè stessi e coscienza delle proprie qualità superiori che, mascherate da death metal brutale e inattaccabile, vengono tradotte in note.
Niente da aggiungere, nè da criticare per un episodio, nettamente superiore al precedente, che colpisce, piace ed entusiasma senza variazioni nè compromessi. Questi sono stati, sono e saranno i Cannibal Corpse; con o senza dubbi.