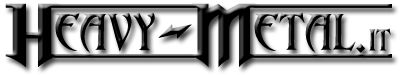Anno di grazia 1994. L’era grunge è a un passo dall’estinzione. Cobain decide di imbracciare un fucile, puntarlo contro di sé e premere il grilletto. L’era dello spleen nella musica è ad un bivio. Forse troppe barriere sono state infrante e gridare il proprio dolore al mondo con litanie metalliche sembra diventato un esercizio di maniera. Jonathan Davis, Fred Durst e Maynard James Keenan sono poco meno che caricature di martiri del post-rock. Ecco che fa la sua comparsa, in questo oceano di autocommiserazione, un ragazzo sui ventotto anni, dal carattere un po’ introverso, sulla cui opaca fascinazione non si può discutere. E’ Trent Reznor, nume tutelare dei Nine Inch Nails, ed ha alle spalle già un full-lenght ed un ep (“Pretty Hate Machine”, “Broken”): molti vedono in lui il futuro della decadenza nel rock estremo, ma la sua pur rilevante notorietà è ancora poco più che di culto.
Anno di grazia 1994. Esce “The Downward Spiral”. E’ il secondo album dei Nine Inch Nails. Fa la sua comparsa sugli scaffali dei negozi di dischi in una confezione gialla con striature ebano, dove poggiate stanno crisalidi che paiono ombre di loro stesse. La campagna promozionale del disco poggia essenzialmente sull’alone di mistero che ne ha circondato il luogo dell’incisione (niente meno che la casa di Sharon Tate) e su un video clip un po’ surreale che accompagna una cantilena essenziale sporcata da un ritornello osceno (“Closer”). Se con gli occhi di adesso si riuscisse a focalizzare il luogo e il tempo di “The Downward Spiral” sarebbe quasi sconvolgente scoprire che ha venduto qualcosa come due milioni e mezzo di copie. A sorprendere di più, forse, è la consapevolezza che i contenuti del disco in questione sono così disturbanti da rendere un successo commerciale del tutto non ipotizzabile. Se lo proporzioniamo direttamente al valore artistico, Trent Reznor il suo successo lo ha meritato tutto.
“La spirale verso il basso”, come recita il titolo, è una sorta di viaggio all’inferno. Il manifesto generazionale dei perduti, degli psicotici, dei frustrati. “Mr Self Destruct” apre il sipario con sorde esplosioni di proiettili, poi irrompe con dirompenza una lastra di elettricità distorta sotto la quale oscilla una specie di martello pneumatico. La voce di Reznor accompagna il tutto con tono lascivo e sensuale. Una sorta di Swans che coverizzano i Ministry. “Piggy” è un furioso climax di sperimentazione rock, con ritmiche di batteria intricate e molto in evidenza. Reznor continua a recitare con la consueta morbosità. Il suo timbro è pulito, ma l’interpretazione, a metà tra la glacialità di un assassino seriale e l’ossessività di uno stupratore, dona al tutto una patina di inusuale terrore. “Heresy” è furioso techno-metal con liriche ad un passo dall’hardcore, “March Of The Pigs” è rabbia incontrollata spezzata da momenti di buio apparente.
“Closer” è il pezzo più famoso dei Nine Inch Nails, con quel ritmo ballabile, con i rantoli eretici di Trent, con i tasti di pianoforte a sfumare in coda. Il nichilismo assoluto del disco continua con il trittico “Ruiner”, “The Becoming” e “I Do Not Want This”, in sostanza la forma perfetta di elettronica applicata al metal e al rock (sentire l’assolo di chitarra a metà di “Ruiner”, pochi secondi di furore autoreferenziale che sanno molto di spartiacque). “Big Man With A Gun” è ultracore digitale, un minuto e mezzo di istigazione all’omicidio che da solo spazza via tutta la discografia degli Atari Teenage Riot. “A Warm Place” è ambient esistenziale che ricorda molto Badalamenti, “Eraser” e “Reptile” sono altre marce verso l’annientamento di se stessi. La title-track fa da apripista (con supponenza straordinaria) a “Hurt”, struggente folk sporcato da eroina che si conclude con la speranza sotterrata da tonnellate di rumore bianco.
Tutto questo in un solo disco. Una quantità di idee impressionante. Non solo lo sfogo di un patetico maniaco sessuale, quanto la capacità unica di rendere umano e riflettente un suono che ha sempre viaggiato troppo in profondità per essere afferrato. L’industrial diventa fenomeno di massa. Dove Michael Gira, i Killing Joke, i Ministry e gli Einstrurzende Neubauten hanno fallito, Trent Reznor trionfa. E lo fa mettendosi a nudo. L’anima di un uomo è alla portata di tutti, pur attraverso stridori e suoni che annientano la percezione. E’ un’anima che conosciamo. E’ la nostra anima.
Anno di grazia 1994. Le nubi si addensano e non promettono nulla di buono. I pusher e i divoratori di coscienze hanno un sacco di lavoro. Il sangue è ovunque. I muri sono sporchi e quando si cammina non ci si guarda più negli occhi.
Parlare di tutto questo è difficile, ma c’è chi ha avuto il coraggio di farlo, perché ha parlato di se stesso. E ha fatto un ottimo lavoro.