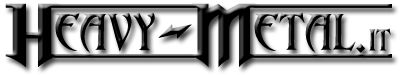Hanno studiato bene la lezione impartita dalla tradizione death statunitense e ne hanno assorbito, con scaltrezza e furbizia, le re-interpretazioni più moderne e “audaci”. Sono i Dying Humanity, cinque musicisti tedeschi che rimanendo a cavallo tra classico e moderno, pur nella propria incapacità di proporre alcuna novità, forgiano un disco quantomeno piacevole ed interessante.
Otto brani decisamente violenti ed aggressivi che, rappresentando un esordio, si fanno notare e gradire per la maturità e l’organicità espressa. La formazione in questione, seppur giovane, conosce il proprio target e sa come perseguirlo a dovere. E’ così che, con fluidità e tanti richiami più o meno pesanti, viene lanciato un prodotto che si lascia almeno ascoltare per valori prescindenti dall’originalità. Temi musicali già ascoltati miriadi di volte ma arricchiti da una personalità interpretativa e da quell’atteggiamento moderno che ha fatto la fortuna di band come Job For A Cowboy e All Shall Perish. Dai primi, infatti, la band teutonica pesca a piene mani il flavour nuovo e speculativo mentre, dai secondi, va a rubare la riproposizione in chiave deathcore della tano abusata scena svedese. Ciò che emerge, complice un’ottima produzione, è un disco piacevole, ricco di armonizzazioni che, insieme, spezzano ed accompagnano la brutalità di fondo; un lavoro sempre al confine tra il sudore nella produzione di un riffing massiccio ed i neuroni necessari per interfacciare una così vasta varietà. In questo scenario, se il lavoro del singer piace ed entusiasma per la sua intraprendenza nel cambiare con successo registro da scream a growl a seconda delle esigenze, non si può dire lo stesso di una sezione ritmica poco fantasiosa e monotona (a riguardo si paragonino di ”The Last Breath” e “Paranoia”). Un quadro godibile, a tratti fascinoso ma sempre accompagnato dalla sensazione che qualcosa sia migliorabile con poco sforzo. Piacevoli chiaroscuri in attesa che il talento diventi concretezza e che l’ispirazione diventi paternità di idee.