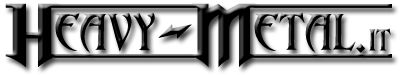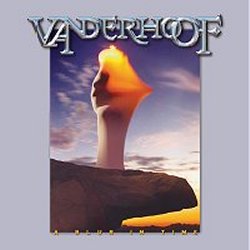Secondo album in studio per il progetto parallelo di Kurdt Vanderhoof e Kirk Arrington, più noti per essere rispettivamente chitarrista e batterista dei Metal Church, una vera istituzione per quanto riguarda l’heavy metal americano. I Vanderhoof si discostano però in maniera abbastanza marcata dalla band madre, almeno per quanto riguarda lo stile musicale, che si ispira dichiaratamente a gruppi degli anni ’70 come Deep Purple, Uriah Heep e Yes: in particolar modo, Kurdt Vanderhoof e soci vorrebbero riprendere quel fantastico sound che combinava gli Hammond e i mini Moog con le chitarre distrorte. Impresa coraggiosa e decisamente ardua, perchè, diciamolo chiaramente, i Jon Lord, i Ken Hensley e i Rick Wakeman non nascono certo tutti gli anni e sarebbe davvero impossibile, oltre che pretenzioso, riuscire a riproporne lo stile in maniera adeguata.
I Vanderhoof, con questo nuovo disco, ci regalano una manciata di canzoni senz’altro godibili, di ampio respiro, molto ben suonate e soprattutto molto melodiche, che riescono nell’intento di ispirarsi al rock dei seventies senza scadere nel plagio, ma che comunque sono ben lontane dal sound dei gruppi sopra citati. Le tastiere dell’esperto Brian Cokeley (Quiet Riot, Earth Wind & Fire, Vanilla Fudge e The Commodores fra le sue collaborazioni) non arrivano quasi mai a ricoprire un ruolo primario all’interno delle canzoni, pur donando ad esse un notevole tocco di classe e di eleganza. Questo è forse dovuto al fatto che i Vanderhoof hanno cercato di puntare più sulla forma canzone che sui virtuosismi fini a se’ stessi, il che è senza dubbio un punto a loro favore, considerato anche il genere estremamente melodico che hanno scelto di proporre. Brani come la dinamica “30 Thousand Ft.”, le veloci “Nowhere Train” e “Sonic Blur” e la grintosa “Sleeping Giant” ci mostrano il lato più energico e rockeggiante della band, ed è in questi episodi che le influenze dichiarate si fanno sentire di più, pur mantenendo sempre un sound arioso e accessibile.
La cangiante “High St.”, probabilmente il brano più riuscito, e la melodicissima “If There’s A Song…” rappresentano invece il lato in un certo senso più sperimentale dei Vanderhoof, che arrivano in questi brani ad usare orchestrazioni e strumenti particolari, oltre a citare apertamente gli anni ’60 e i Beatles nel refrain della seconda. In alcuni casi, vedi il francamente inutile strumentale “Surface Of Another Planet” o l’evocativa ma fin troppo lunga “3 AM”, la band si è lasciata un po’ prendere la mano, cadendo nella trappola della prolissità. Se a questo aggiungiamo la prova discreta, ma non certo trascendentale, del cantante Drew Hart, otteniamo un album tutto sommato fresco e piacevole, meritevole senz’altro di almeno un ascolto, pur non esssendo certo un capolavoro che possa far gridare al miracolo. La mia impressione è che la base sia quella giusta, e che i Vanderhoof abbiano i mezzi e il talento per poter migliorare notevolmente in futuro. Nel frattempo, si tratta di un nome sicuramente da tenere d’occhio per quelli fra di voi che apprezzano un tipo di hard rock melodico, elegante e di facile assimilazione.
Apalus Zanzariera con Magneti per Porte, 120 x 240CM - Rete Fine, Tenda Totalmente Magnetica, si Chiude da Sola - Non Accorciabile (Bianca)
25,26 € (a partire da 19 Aprile 2024 20:51 GMT +02:00 - Altre informazioniProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)Anpro Capotasto Chitarra, con 6 Plettri Chitarra, Lega di Zinco Adatto per Chitarra, Violino, Ukulele, Mandolino e Banjo, Venatura del Legno Scuro
Sto recuperando il prezzo.
(a partire da 19 Aprile 2024 21:22 GMT +02:00 - Altre informazioniProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)