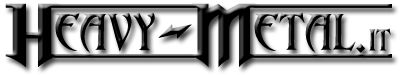E’ possibile fondere due anime, due ambienti, due sfere per certi versi simili ma per altri diametralmente opposte? Ascoltando “Fulton Hill”, la risposta sembrerebbe essere “sì”: da una parte il southern rock degli anni ’70, sporcato da blues e country, dall’altra il metal parossistico ed estremo di casa Relapse fatto di distorsioni selvagge e vocals furibonde.
Un matrimonio certo impegnativo…
Non contenti di essere fra i relativamente pochi gruppi (per fare due nomi, mi sovvengono Down o Sixty Watt Shaman) a sperimentare con sonorità di un certo tipo, gli Alabama Thunderpussy (che nonostante il folle nome provengono da Richmond, Virginia) di “Fulton Hill” riescono addirittura, nei casi migliori, a fare genere a sè.
Oltre ad essere probabilmente il miglior lavoro finora dato alle stampe dai cinque musicisti, l’album presenta infatti una crescita artistica notevole, un arricchimento che porta il songwriting a livelli sinora solo sfiorati nei dischi precedenti.
Dopo diversi ascolti, la maggior parte dei pezzi risulta piacevole quando non avvincente: dalla sostenuta “Wage Slave”, a “Lunar Eclipse”, passando per “Infested” e per l’intro in crescendo “Such is Life”, gli A.T. mostrano una notevole maturazione che si manifesta in forma di brani scorrevoli e ben congegnati, arricchiti da eccitanti armonizzazioni a più chitarre nonchè da lunghi assoli (quasi centellinati, stranamente vedendone la qualità, nei dischi precedenti), creando così un sound che non si limita all’aggressione frontale ma che va a ricercare anche una propria profondità.
Se il nuovo cantante John Wells non fa troppo rimpiangere il suo predecessore nei momenti maggiormente heavy, la vera sorpresa si ha nei pezzi più spiccatamente southern, dove l’ex “signor nessuno” sfodera una voce calda, ruvida e profonda che fa letteralmente decollare l’album.
Brani come “Three Stars”, “Alone Again” o la sofferta ballad “Do Not” farebbero certamente la gioia di chi ha amato e tuttora ama la grande tradizione fatta di nomi come Molly Hatchet, Blackfoot, Allman Brothers ed ovviamente Lynyrd Skynyrd.
Purtroppo, non tutto va per il verso giusto. Anche a causa della notevole durata, oltre 67 minuti, l’album non risparmia momenti di stanca, specie nella seconda parte (“Blasphemy, “Sociopath Shitlist”), ed il posizionamento in coda della lunga suite/jam “Struggling for Balance” (a tratti interessante ma decisamente indigeribile se assunta dopo il resto del disco) di certo non aiuta.
Tirando le somme, ci troviamo di fronte ad un lavoro maturo, non sempre impeccabile ed ostico ai primi ascolti, ma comunque senz’altro valido: ascolto obbligato per chi già apprezza il gruppo, potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa anche per chi magari non lo ha mai sentito neppure nominare.